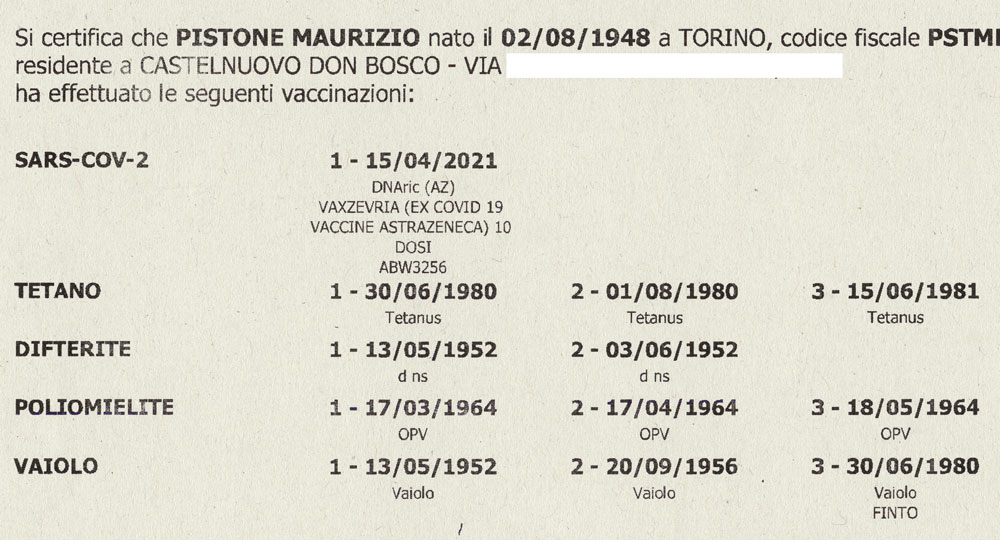Tra le formulette riduttive che si dicono sulla lingua, una è quella che definisce l’italiano “un dialetto che ha fatto carriera”.
In breve, Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio scrivevano nel dialetto della loro città; poi, per motivi oscuri – una torbida cospirazione di accademici parrucconi, di aspiranti condottieri di eserciti, di apprendisti ammiragli di flotte – chissà come, questo dialetto è stato imposto come lingua a tutta l’Italia.
Non è proprio così.
Per prima cosa, la Firenze di Dante, Francesco, Giovanni, non è un piccolo borgo di gente semplice dove si parla come si magna. La Firenze del ‘300 è una città con una popolazione molto composita. C’è un’aristocrazia che vanta gloriose origini, ma in realtà è formata in massima parte da arrampicatori sociali, grandi proprietari terrieri che non sdegnano di sporcarsi le mani con il lavoro e soprattutto con il denaro, popolani arricchiti che si danno arie da gran signori. Sono emersi dal nulla in diverse fasi della storia della città, ma all’inizio sono stati tutti “gente nova e subiti guadagni”. E poi c’è il “popolo”, che non è il “popolo” dei populisti d’ogni tempo, ma un mondo variopinto di nuove professioni che cercano di ritagliarsi nell’economia in forte crescita del tempo il loro spazio di privilegio, sempre con la tentazione di fare il gran salto verso uno stile di vita più signorile.
E tutto questo mondo in fermento non è mai stata chiuso “dentro la cerchia di Fiorenza antica”, ma ha sempre avuto rapporti molto stretti con il mondo degli affari, della politica, della cultura italiana ed europea con un raggio di interessi sempre più ampio.
In questa città, che è l’esatto contrario della chiusura municipale, si forma Dante. E la sua formazione si nutre della cultura che all’epoca era la cultura d’avanguardia. Dante conosce la poesia provenzale e la poesia siciliana. E di nuovo bisogna ricordare che né il provenzale trovadorico, né il siciliano della scuola siciliana, sono la rustica favella del buon popolo non ancora corrotto dall’intellettualismo radical chic. Si tratta in entrambi i casi di lingue altamente formalizzate, filtrate attraverso il gioco letterario di circoli esclusivi, che si sono sforzati il più possibile di uscire dal localismo per costruire due koinè letterarie, quella della Francia meridionale (che comprende anche la Catalogna e una buona fetta di Padania) e quella dell’Italia meridionale. In più, Dante conosce il romanzo in lingua d’oïl, che non è più da secoli la lingua della contea di Parigi, ma una lingua già fortemente internazionalizzata.
Quando Dante comincia a scrivere, è in pieno vigore la scuola che lui stesso chiama “stil novo”. E lo stil novo non è la poesia siciliana tradotta in fiorentino. Lo stil novo nasce già come una corrente più ampia non solo della dimensione cittadina, ma regionale. Il primo Guido è un bolognese, altri vengono da altre città della Toscana.
Dante scrive parecchio anche in latino. Conosce a memoria tutta l’Eneide, ma non è in quel latino che scrive. Il suo è latino medievale. Ed il latino medievale è quello che i nostri linguisti da social chiamerebbero “una lingua che non esiste”, una lingua che non è mai compressa nella gabbia delle regolette delle buone maestre di una volta, quelle che ti facevano segnacci blu se azzardavi un “famigliare” con la g. Esistono tanti latini medievali quanti sono i centri di cultura medievale, anzi, tanti latini quanti sono gli scrittori. Il latino medievale porta sempre l’impronta fortissima del suo autore; e in alcuni, diventa terreno di vera creatività, di sperimentazione.
Firenze è la città dove si è formato Dante; ma non è la città dove è stata scritta la Divina Commedia.
Il trauma dell’esilio, dello sradicamento, l’affannosa inutile ricerca di un posto dove mettere nuove radici, è stato anche un enorme allargamento della sua prospettiva linguistica.
Ci sono nella vita di Dante due esperienze bolognesi, una prima dell’esilio, l’altra dopo. Bologna è un centro dove affluiscono maestri e allievi da tutta Italia e da tutta Europa, un centro di dibattito e di contaminazioni. Il bolognese dei bolognesi veraci è un dialetto dove ogni quartiere cittadino ha un dialetto tutto suo, ma non è certo quello il bolognese a cui Dante assegna un ruolo molto importante nella formazione del “volgare illustre”.
Poi c’è il periodo veronese, a contatto con la grande aristocrazia del nord-est. Poi va (forse) a Parigi, forse a Padova: altre due città universitarie.
Il De Vulgari Eloquentia è un tentativo di cavar fuori il sugo di tutte queste esperienze; è il primo esempio in tutta Europa di un’analisi scientifica della lingua moderna, ed il fondamento di una lingua che non esiste ancora, ma di cui ci sono tutte le premesse: una lingua che nasca già con una prospettiva né municipale né regionale, ma nazionale.
Poi c’è la Divina Commedia, e qui il discorso è breve, perché tutti voi la conoscete a memoria. E tutti voi sapete che la lingua della Commedia è una lingua in cui l’autore trasferisce la grande molteplicità delle sue esperienze culturali e linguistiche. Una lingua che non parte da Firenze per parlare ai fiorentini, ma parte da questo gran fermento linguistico per parlare ad un’Italia che è già in formazione.
Passiamo a Francesco Petrarca, un fiorentino che a Firenze c’è stato forse tre settimane in tutta la sua vita.
Francesco nasce ad Avignone, figlio di un guelfo bianco che ha subito lo stesso sradicamento di Dante. Ed anche Avignone è una città in gran subbuglio, dove si deve trovare alloggio a tutta la corte papale che s’è da poco trasferita là. Corte papale vuol dire corte internazionale, una corte dove ovviamente si parla parecchio francese. Non sono competente dell’argomento, quindi non saprei dire cosa significhi “francese” nell’Avignone dei papi; ma sicuramente è una lingua di respiro molto ampio.
Ormai della grande stagione trovadorica arriva appena un’eco, e non sembra che sia questa una grande fonte di ispirazione per Francesco.
La prima lingua di riferimento per lui è sicuramente il latino, lingua nella quale scrive la quasi totalità della sua opera. Il latino di Petrarca è ormai oltre il latino medievale, siamo alle premesse dell’umanesimo, e questa lingua, che è contemporaneamente lingua della cultura, lingua della liturgia e del diritto canonico, lingua della diplomazia papale, in lui si sforza di modellarsi sui grandi modelli classici e postclassici, avendo come faro nel buio il latino di Agostino per guardare ad un’Europa che cerca di scrollarsi di dosso il medioevo.
E poi c’è il fiorentino, che ovviamente per lui è in primo luogo il dialetto del papà, un certo Petracco, esule senza qualità. Lo stesso fiorentino che aveva sentito Dante da bambino. Non è ovviamente quello che usa Francesco nelle due uniche operette in volgare: una raccolta di poesie, un frammento di poema allegorico. Per Francesco il fiorentino è la parlata di una città per la quale si prova una nostalgia così grande che si fa di tutto per non tornarci, perché si sa che non si reggerebbe alla delusione.
Il fiorentino di Petrarca quindi non è più il fiorentino di Firenze, ma quel volgare “che non esiste”, rispetto al quale la stessa lingua mutevole, sperimentale, tumultuosa di Dante pecca di municipalismo. Francesco cerca di partire non dalla Commedia, ma dall’esperienza lirica dello stil novo. Però Dante ha contato, e molto, non tanto come modello formale, ma come esempio di una poesia che rifugge ormai dal semplice gioco letterario di società, e si sforza di dire cose. In Dante questo porta a una lingua aspra, varia e mutevole com’è aspro, vario e mutevole il mondo. In Francesco lo sforzo di una lingua essenziale, che nel vocabolario specialistico e ristretto della lirica cortese trova ampia dimora, deve raggiungere una semplicità che non è innocenza primordiale, ma distillazione di studio. La lingua di Francesco deve giocare sulle microvarianti, per mostrar che potea la lingua nostra. È la lingua finissima dell’arte del tardo Gotico, premessa del Rinascimento, la lingua del mutevole gioco di consonanze della polifonia. È in questo senso, non nella maniacale selezione lessicale, che va intesa l’importanza capitale di Francesco nella storia dell’italiano.
Visto che siete già stufi di leggere come io sono stanco di scrivere, dirò poche parole – ma non perche sia meno importante degli altri – di Giovanni Boccaccio.
Dei tre, è quello per il quale la produzione latina è meno importante. Ma è quello che ha dato veramente corpo ad una lingua moderna, trasportando in prosa quello che i primi due avevano fatto prevalentemente, o esclusivaente, in poesia.
Certo, Giovanni è fiorentino. Ma è un fiorentino che ha trascorso gran parte della giovinezza a Napoli: sede di una corte internazionale di lingua francese, che prima era sotto una corte internazionale di lingua tedesca. Giovanni è un uomo di corte che quando può scappa per i mercati e i quartieri malfamati della grande città portuale; gioca a ingaglioffirsi, e poi a rivestire di panni curiali il resoconto delle sue avventure.
Giovanni ha una venerazione sconfinata per Dante; e soffre di un discreto complesso di inferiorità verso il suo corrispondente Francesco. Ma di entrambi assimila e porta al massimo grado la lezione: totale aderenza al reale, una naturalezza che è il massimo traguardo dell’arte.
È questa la lingua che Dante, Francesco, Giovanni hanno consegnato all’Italia. Una lingua che fin da allora nessuno, in Italia, ha mai pensato di chiamare “dialetto di Firenze”.