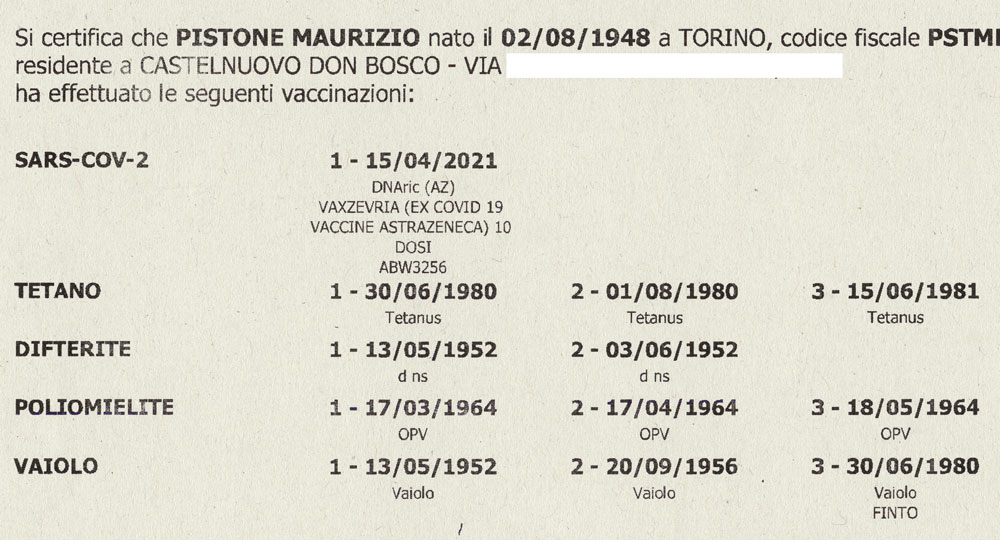Sono abbastanza vecchio per ricordarmi l’Italia del 1961.
Sono passati cinquant’anni, e gli enormi palazzoni dell’Esposizione sulle rive del Po sono ancora lì, nessuno li ha buttati giù, e nessuno ha mai trovato veramente un modo per utilizzarli. Memorabili monumenti dell’ingegneria, quasi del tutto inutili.
Mio figlio ha fatto scuola di roccia nel Palazzo a Vela, prima che venisse riutilizzato per le Olimpiadi del 2006. Vi erano pareti artificiali vertiginose. Il palazzo di Nervi si trova su tutti i libri di storia dell’architettura; ma è vuoto, e coperto di ruggine.
Nel 1961 a Roma c’era Andreotti. A Torino c’era la Fiat.
A Torino c’erano anche dei quartieri poco raccomandabili, pieni di immigrati: Porta Palazzo, San Salvario. Le vie della periferia erano piene di prostitute.
La città aveva un 10% circa di abitanti più di oggi. Le strade erano più o meno le stesse. In centro vi erano due grandi corsi dai pomposi nomi celebrativi: Corso Stati Uniti, e Corso Unione Sovietica. Cosa notabile: ci sono ancora, e si chiamano allo stesso modo.
Non c’era la metropolitana, le linee tranviarie erano più o meno le stesse, c’era un po’ meno macchine, ma l’aria era molto più inquinata. Riscaldamento domestico a carbone o a nafta. Niente metano.
La scuola. Nel 1961 facevo la seconda media. Ero fortunato, molti dei miei coetanei frequentavano i “tre corsi” dell’Avviamento, e poi a lavorare a 14 anni.
Poi avrei fatto il mio Liceo, dall’inizio alla fine, in giacca e cravatta. Ma non lasciatevi raccontare delle frottole: a parte l’abbigliamento, era più o meno come adesso.
La gente in casa aveva il frigorifero, la radio, il telefono, qualcuno la televisione. In bianco e nero, con un solo canale. Ma era pur sempre la Rai Tivvù. C’erano Mike Buongiorno, Emilio Fede, Piero Angela.
Se si voleva uscire la sera, si poteva andare al cinema: la scelta era tra superproduzioni americane, oppure commediole italiane, per lo più volgarucce e fatte in economia.
Fuori città, lì sì, c’era una grande differenza. C’erano ancora gli ultimi contadini, quelli che vivevano con sei vacche nella stalla, e il fieno ammucchiato con i forconi nel fienile. Ma sarebbero durati poco.
Nel mondo, c’era un po’ di guerre qua e là. L’uomo non era ancora andato sulla Luna, ma c’erano già missili e aerei supersonici capaci di portare bombe atomiche dall’altra parte del globo.
E soprattutto, il mondo conosceva da anni l’invasione della plastica, onnipresente.
Insomma, immaginiamo una macchina del tempo, che in un attimo porti un uomo del 1961 nel 2011, e un altro dal 2011 al 1961. Le cose sarebbero un po’ diverse, ma quanto ci metterebbero ad adattarsi?
Se proprio uno ci pensa su, tra la nostra vita nel 1961 e quella di oggi, la differenza più grande è che oggi io posso salire in macchina nel primo pomeriggio, e se non mi addormento in autostrada, faccio cena a Lubiana, senza che nessuno mi abbia chiesto chi sei dove vai. Pago il conto con i soldi che ho in tasca, se non ho contanti, esibisco un pezzo di plastica. Cinquant’anni fa, perfino andare da Torino a Mentone comportava un passaggio di frontiera, documenti, cambio, niente da dichiarare?
Ah, dimenticavo: oggi ci portiamo il telefono in tasca.
Prendiamo la stessa macchina del tempo, e facciamo un salto dal 1961 al 1911.
Sono sempre gli stessi cinquant’anni, ma tanto per cominciare, dobbiamo scavalcare cinque guerre.
Per celebrare il 50° dell’Unità, s’è abbattuto un pezzo di Campidoglio per costruire un enorme monumento, già all’epoca definito unanimemente orrendo. Giovanni Pascoli, per l’occasione, ha scritto due sterminati poemi in lingua latina: l’Hymnus in Romam, e l’Hymnus in Taurinos =>.
Al Quirinale c’è un Re appassionato di numismatica, con il suo corteggio di principi di Piemonte, di Genova ecc. La bandiera d’Italia ha lo scudo sabaudo nel centro(*). Non votano ancora le donne, e neppure tutti i maschi.
Le donne portano gonne fino a terra; gli uomini rispettabili si massacrano con uno stretto ed alto colletto rigido, in celluloide, anche in piena estate. Non esiste lo shampoo, non ci si asciuga i capelli col fòn, anche le case borghesi raccolgono, accanto al cesso, un discreto blocchetto di pezzi di carta di giornale, per la necessaria pulizia. Ma nella maggior parte delle case, anche in città, è considerato normale andare a farla in un gabbiotto in cortile. Sempre in cortile, ci sono le fontane per il lavaggio di panni. I regolamenti condominiali vietano di fare il bucato in casa. Niente pannolini per i neonati. Però chi può permetterselo trova già il Borotalco in farmacia.
(Naturalmente, niente plastica. Guardatevi in giro per casa. Anche una casa del 1961. Togliete tutti gli oggetti in qualche materiale sintetico. Dite che cosa vi rimane.)
Mussolini è un giovane deputato socialista. D’Annunzio, inseguito dai creditori, è scappato in Francia. A Parigi si parla ancora di un duello di cui s’è reso protagonista, due anni prima, F.T. Marinetti.
Le città sono decisamente più piccole di adesso. A Torino la campagna comincia, ad ovest, dopo Corso Tassoni; a sud, percorrendo corso Peschiera si vedono ancora, da una parte e dall’altra, vaste aree non edificate.
Sorgono le prime fabbriche. C’è ovviamente la Fiat, in mezzo a dozzine di altre piccole aziende, ancora incerte tra le quattro ruote e il biciclo, oppure, come la gloriosa Chiribiri, tra le automobili e gli aereoplani. Ma sono sicuro che sulla totalità della popolazione italiana, la maggioranza non ha mai visto né un’automobile, né un aeroplano; e forse neanche una bicicletta. E questo, a prescindere dalle differenze tecniche fra i mezzi.
La Fiat fa anche macchine da corsa: il modello più potente ha 14.000 di cilindrata, e tocca i 165 kmh. Gli aerei del 1911, be’, lasciamo perdere. Cinematografo, fonografo, radio, telefono, ecc: diavolerie moderne, chissà se avranno un futuro.
Si va in America con il vapore; per i più, dati costo e lunghezza del viaggio, non ci sarà ritorno.
Le città stanno realizzando l’illuminazione pubblica: ma alcune non si sono ancora decise tra il gas e l’elettricità.
Gli analfabeti sono quasi la metà della popolazione: un po’ più le femmine che i maschi. Quasi il 50% della popolazione attiva lavora nei campi.
Insomma, avete capito dove voglio arrivare. Negli ultimi cent’anni, la storia ha viaggiato a due velocità diversissime. Per i primi cinquant’anni ha cavalcato come una Walkiria col culo pieno di peperoncino; poi, ha poltroneggiato per il secondo mezzo secolo.
(*)Ai tempi del Fascio, tutti avevano in casa una bandiera, da esporre nelle festività di precetto. L’abitudine rimase ancora per qualche anno dopo la guerra, ma ben pochi si erano sobbarcati la spesa di un drappo repubblicano. Alcuni miei zii tiravano fuori quello vecchio, ma lo lasciavano mezzo arrotolato, in modo che la croce di San Maurizio non fosse troppo visibile. Non era nostalgia monarchica, solo tirchieria.
[Torna al testo ^]